Gone Girl tiene allo storytelling. Tiene in primo luogo, e com’è consueto per un thriller girato da Fincher, a disporre gli elementi in modo da far credere allo spettatore di sapere che tipo di storia si sta raccontando, per poi complicare la matassa e sorprendere con rivolgimenti ancora più dark. O meglio – per usare un altro termine inglese che renda in verità sia il carattere inquietante che quello grottesco, fuori dagli schemi – ancora più fucked up (e già Fight Club lo era parecchio). Inoltre, come nei più fini casi di storytelling, agisce l’attenzione al dettaglio: i fan di Fincher sanno bene, ad esempio, che in moltissime scene dei suoi film ciò che accade sullo schermo non si concentra semplicemente sui dialoghi, sulla stretta interazione esplicitamente esposta tra un personaggio e l’altro, ma che gli strumenti della settima arte sono sempre sfruttati nel potere della narrazione visuale, oltre che verbale. L’impronta fincheriana insiste sempre su questo punto, dato che le sceneggiature generalmente sono scritte da qualcun altro (in questo caso Gillian Flynn, autrice del libro omonimo). Ad esempio l’uso del montaggio qui risulta azzeccatissimo, contrapponendo nel momento giusto più linee narrative – quella di Nick e quella di Amy – e alternando fra passato e presente, fra complicata pretesa e cruda realtà. Più in generale, Fincher dà ai suoi film un’impronta fortemente riconoscibile, motivo per cui è un vero e proprio autore e non semplicemente un mestierante: i close-up, ad esempio, non sono sfruttati continuamente, né arbitrariamente, ma solo quando hanno una precisa funzione, ad esempio quella di indicare un particolare dettaglio o indizio utile ai labirinti della trama, magari ancora prima che questo sia portato all’attenzione dai personaggi.

Fincher usa più frequentemente dei piani ampi, che inseriscano sempre i personaggi in un contesto, un’ambientazione da cui trarre molte informazioni su di loro e sul loro mondo – sono sempre inquadrature molto nette, con un senso dello spazio tendente al perfezionismo. E ciò che lo definisce ulteriormente è che, come dice lui stesso: «Some people go to the movies to be reminded that everything’s okay. I don’t make those kinds of movies». Una frase, questa, che di per sé risulta applicabile a molti film e autori; attraverso Gone Girl, tuttavia, la si può comprendere al meglio, dal momento che vale – perlomeno parzialmente – anche per gli altri suoi lavori. La musica ambient adoperata sottolinea un’aria continuamente tesa, a tratti incrementata verso un effetto serrato, sospeso; la fotografia ha sempre colori saturati, la luce quindi è sottratta, gli ambienti spesso sono inospitali. Prendiamo la casa dei coniugi Dunne, luogo in cui si annida sia una scena del crimine che molto altro: si tratta del backstage, contrapposto idealmente all’immagine da offrire all’opinione pubblica, ai media. Si tratta dei panni sporchi da nascondere, e del senso di sporco emotivo di un matrimonio che si è lasciato dietro i lustri della luna di miele per entrare nel sentimento stanco, nell’accomodamento vagamente nauseato.
Qui, in particolare, lo spazio domestico è decisamente un arredamento benestante, quindi – rispetto ad altri ambienti degradati presenti in Fight Club o Seven – in questo caso è tutto pulito, tutto ordinato. La casa parla eloquentemente anche di che tipo di relazione si vuole instaurare con gli spettatori, coi visitatori (la pulizia è sempre segno di rispettabilità, di rassicurante, accogliente linearità); gli spazi sono sproporzionati rispetto alle persone che ci abitano, tanto che spesso Nick (Ben Affleck), aggirandosi per una casa da cui la moglie è scomparsa misteriosamente, risulta ridicolo, mai del tutto a suo agio – la casa di sua sorella, al contrario, sembra ricondurlo molto più facilmente a un senso di domesticità, con il suo ambiente decisamente più ristretto, che si allontana dal tocco un po’ minimalista e un po’ glaciale della moglie. Più semplicemente, tra l’altro, casa sua ora è in mano alla polizia, che deve rintracciare chirurgicamente ogni segno di qualsiasi tipo di storia sia avvenuta qui. Tracce di sangue, segni sul pavimento, il modo in cui alcuni oggetti sono stati mossi o come – e qui è l’importanza della disposizione degli oggetti in scena fuori dall’apparente focus primario dello spettatore – non sono stati affatto mossi. Questa casa racconta qualcosa, racconta una vita, ma specialmente racconta un fattaccio.

Si diceva, infatti, dell’importanza dello storytelling, qui estremamente autoconsapevole rispetto a quale effetto si voglia ottenere dal proprio pubblico, che sia la polizia, o i media, o entrambi. Non solo Fincher in primo luogo deve guidare la storia di Gillian Flynn, ma i suoi personaggi a loro volta sono impegnati a inscenare storie, e queste storie agiscono come in un campo di battaglia, dove una fine modulazione correttiva del proprio personaggio pubblico porta acqua al mulino di uno invece che dell’altro, aggiusta l’immagine, porta gli spettatori – in primis quelli della televisione, attraverso cui questa storia di cronaca nera viene riportata passo per passo, come per tradizione in maniera morbosa, sensazionalistica, un po’ trash – a cambiare la propria impressione su di loro.
Quando Nick Dunne rileva la scomparsa di sua moglie, il mondo dei media e la sua immagine pubblica non sono ancora stati controllati con cautela. Prima di allora, Nick si percepiva semplicemente come un fruitore dei media, e non doveva preoccuparsi della maniera in cui ne era agente: dopotutto, le luci abbaglianti e la calca di giornalisti non avevano motivo di avercela con lui. Ma i media, se non controllati, quasi ammaestrati (qua hanno una ricezione fin troppo credula) costruiranno da sé la tua storia, inventeranno chi sei, e lo faranno appigliandosi a qualsiasi segno esteriore possa vendere un’idea preconcetta, un’idea facile, che entri immediatamente in una categoria, in un tipo: ad esempio quella del marito-mostro da accusare, demonizzare, del marito violento, indifferente, del sociopatico, dell’assassino – il tutto, va da sé, sempre in maniera assolutamente disinformata su questi fenomeni psicologici, o in generale sulla stretta logicità delle indagini poliziesche.

Si parla tanto di tipi generici tramite, ad esempio, epiteti (“la ragazza in gamba”, “il bifolco”, “la megera assillante”, “la stronza dispotica”, “il bravo ragazzo”), ed è interessante come si tiri la corda tra ciò che effettivamente si è e come si debba invece ricoprire un ruolo subito riconoscibile per gli altri. Questo è vero anche nell’ambito specifico del matrimonio: la donna-poliziotto e l’uomo-cane, il modo in cui allontanarsi da questo ruolo e ricoprirne un altro, la coppia complice e impeccabile, la coppia dalla vita sessuale sempre costante, intraprendente, famelica. Curioso è come si sia quasi costretti a recitare una parte, in modo che la materia gretta della vita, molto meno sensazionale se lasciata a sé stessa in un contesto ordinario, possa reggere la fame di glamour di un certo tipo di cultura mediatica bassa. Basti pensare a come chiunque si rivolga alle telecamere per parlare di Amy usi sempre le stesse parole: bellissima, intelligente, gentile, affascinante, saggia, e di nuovo bellissima (che è sempre il primo aggettivo: questo dettaglio, evidentemente voluto, sottolinea l’importanza dell’apparenza fisica della donna per inquadrare subito il suo valore, in modo sempre superficiale, e per decidere delle aspettative su di lei).
Nick Dunne non è particolarmente intelligente, né sensibile: è una versione un po’ abbruttita dell’everyman. Sin dalle prime scene lo si vede con uno sguardo crucciato (il che suggerisce che possa essere in una situazione infelice, più che neutralmente regolare), ma gli abiti sono anonimi, sono casual. Nick va nel locale della sorella, “The Bar” – quale nome più generico per questa attività? – con un caffè della Starbucks in mano. I dettagli che lo riguardano, nel corso della storia, coinvolgono più marche. Nel caso di Fincher queste non sono mai semplicemente una promozione commerciale, ma suggeriscono – anche con riferimenti precisi – il contesto standard, attuale dei personaggi. Starbucks è effettivamente uno degli stemmi immancabili per un uomo statunitense qualunque. Un uomo che si circonda di videogiochi (ben riconoscibili) per rifuggire a una situazione oppressiva: la sua relazione coniugale incrinata.

Tuttavia Nick è di certo coinvolto in un matrimonio particolare: nel momento in cui la moglie Amy scompare, infatti, non sembra dispiaciuto, ma solo seccato. Come altri personaggi (la moglie, i suoceri), anch’egli dimostra una strana distanza emotiva, che ben si confà all’estetica del film. Questo getta un primo segno di come lo stesso Nick sia coinvolto nell’atmosfera dark: l’espressività decisamente poco malleabile di Affleck, il suo sguardo e la sua fisionomia che mostrano un uomo massiccio ma potenzialmente insipido sono perfetti per il suo ruolo, accentuando anche il tono satirico (perché Fincher sa sempre usare i propri attori, anche se non sono dei maestri di recitazione). Questo dà, alla potenziale storia sentimentale in atto, un sapore immediatamente diminuito, deviante rispetto a qualsiasi aspettative di genere “rosa”. Ma, d’altra parte, per rendersene conto bastava la prima inquadratura del film, con lo sguardo inquietante sul capo di Amy (Rosamund Pike), con quel riferimento fortemente fisico e violento alla sua testa, con i suoi pensieri contenuti in un cranio, in un cervello da srotolare, con la violenza che viene sbattuta in faccia immediatamente e preoccupa, accresciuta poi da quel volgere repentino di Amy verso la camera, verso Nick, con degli occhi folli, freddi e malefici.
La situazione infatti è ingarbugliata: c’è del sangue ma non c’è un corpo, la moglie è una tipa “complicata”, tant’è che le ultime tracce che ha lasciato di sé sono quelle di una caccia al tesoro, tradizione che inscena ad ogni anniversario. Questa caccia al tesoro è una delle tante forme di storytelling, sia visuali che verbali, adottate per vendere una versione, una pista, ma che in realtà conducono a una trama fittizia. Amy, al contrario di Nick, non è una persona qualunque: è una mastermind – come il titolo di un gioco da tavolo tirato fuori da Nick e dalla sorella – e la storia venduta deve infinocchiare abbastanza per rivolgere le cose a suo favore. Una versione di sé stessa è data in pasto alla massa, e non è la prima volta. Amy Dunne è letteralmente cresciuta come feticcio dell’opinione pubblica: il suo passato infatti ha un che di comico, volutamente parodistico. I suoi genitori sono dei famosi scrittori di libri per l’infanzia che hanno forgiato su di lei il personaggio fittizio di Amazing Amy, che realizzava le loro pretese disumane prima di bambina e poi di ragazza perfetta. Un dettaglio lo dice chiaramente: quando Amy, a dieci anni, ha abbandonato il violoncello, l’Amazing Amy dei libri è diventata una violoncellista prodigio.
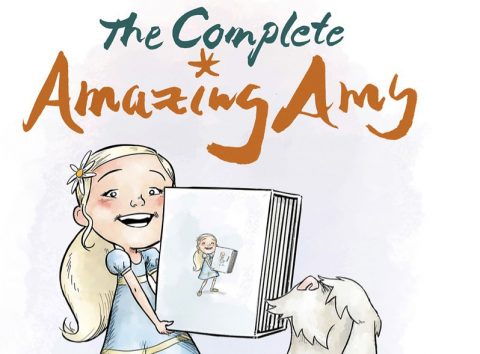
I genitori non hanno, a livello decisamente caricaturale, un rapporto affettivo con lei, ma sono anzi glaciali, eleganti, un po’ aristocratici come la stessa Rosamund Pike: vogliono più che altro che Amy si sottoponga ai riflettori per i fan, che dica la cosa giusta, che si ponga nel modo giusto. Così una vita diventa un mito stereotipato, e si deve ritrarre un profilo di successo secondo gli standard più idioti. Nel momento in cui, nella culla dell’infanzia, tutto è regolato secondo le aspettative riguardanti l’apparizione pubblica, sempre a livelli amazing, scintillanti, di vita invidiabile, con cui gli altri si possano relazionare in quanto centra gli ideali della medietà, non si cresce senza portarne i segni. Nel diario di Amy, che fa parte dell’inscenamento del crimine, la Amy perfetta per accusare Nick è mostrata, e si sceglie di usare la sua voce narrante con intercalari gretti, cattivi, sottolineando per contrasto un siparietto frou frou. Si nota nella finta esaltazione per la propria storia d’amore: Nick che è il ragazzo più “figo” di sempre, la coppia che è la più amabile di sempre («we’re so cute that I want to punch us in the face») oppure il raggiungimento di traguardi che sono generalmente considerati elettrizzanti per una donna comune, ma che qui sono mostrati come spiccia realizzazione personale: «Amazing Fucking Amy is getting fucking married». Il rancore costante sputa addosso al proprio teatrino, e anche addosso alla percezione dello spettatore, scombussolato dal brusco contrasto offerto da Fincher nel montaggio tra la Amy finta e quella vera – quest’ultima in fuga altrove, svelata repentinamente quando getta la penna rosa dal finestrino della macchina.
Amy è uno dei personaggi più disorientanti e allo stesso tempo grotteschi del cinema commerciale degli ultimi anni. Algida, felina, potenzialmente brutale come potenzialmente elegante. Porta all’esasperazione, alla psicopatia (o anche sociopatia) la propria deformazione causata dai media, la propria esigenza di riscontrare piacere, di ricevere attenzione; è pronta a darsi una martellata in faccia per rifinire meglio la propria narrazione, già popolata di segni che dovrebbero parlare da soli. È talmente condizionata dall’idea di accentuata desiderabilità che la condizione comune di un deperimento matrimoniale – ovvero la decrescente valorizzazione data al partner come essere speciale, che porta con sé un’esperienza appagante e di alti livelli – non può che tirare fuori la sua follia ormai radicata. La noncuranza di Nick è un’inconsapevole autocondanna a un’elaborata macchinazione di omicidio. Il suo rapporto – ben meno traviato, più sentito, viscerale – con la sorella gemella è motivo di invidia, di gelosia. Amy deve essere la star. Per chi tiene all’immagine a livelli maniacali, le relazioni personali e l’amore diventano una questione di potere, di fascinazione calcolata, un gioco strategico in mezzo a vari giochi strategici attuati durante il film.

Le colpe di Nick, riscontrabili in tantissimi matrimoni e ben lontane dall’acuta tragedia, sono ingigantite da Amy, diventano onte da tragedia greca degna di sangue, di morte. Amy, poi, è cresciuta appunto nell’arte dei cantastorie di medio-basso livello, così è estremamente consapevole della maniera in cui può rivolgere i media, di cui prevede accuratamente la reazione psicologia, a proprio favore, per punire la disattesa della propria favola personale. Amy sa delle falsità della medietà statunitense, della loro favola improponibile, ma la vuole lo stesso: ne va della sua stabilità psicologica. Non è il caso di prendere troppo sul serio questo personaggio, vedendovi istanze pericolose di “femminazismo” o di maschilismo (nella maniera in cui inscena una vittimizzazione della donna standardizzata per tornaconto personale): Amy è decisamente troppo folle, cartoonesca, fuori dagli schemi per poter essere ricondotta ad un normale discorso di genere che non risulti pesantemente condizionato dai particolari della storia. Tuttavia, il tipo di cultura mediatica a cui è asservita dice molto sui ruoli di genere predefiniti, qui esposti cinicamente, crudemente, con un ghigno, che la guidano più o meno consciamente. È motivo, ad esempio, di immediato discredito dell’uomo se la donna è quella che gestisce le finanze, se è quella che ha in mano i soldi, le carte, se è suo il nome sulle intestazioni (anche se qui tutto questo agisce anche, e chiaramente, come un’altra istanza di potere di una relazione malsana, volutamente esagerata).

Si manipola quindi il preconcetto, lo standard, il normale. Si tratta allora di strumenti tattici di una protagonista femminile assolutamente anormale, e suo marito, una volta compreso il gioco, deve saper usare le proprie abilità per essere all’altezza. Fincher stesso gioca nei toni della storia, mostra i giochi di Amy nel momento più appropriato, gioca con la sensazione di vaga paura per la propria sicurezza con inquadrature di tutto rispetto, gioca con questo personaggio e gioca con lo spettatore. E – nel giocare – intrattiene bene, racconta bene.
