Per certi amanti dell’indie, ritrovarsi a parlare dei National è un po’ come prendere l’abituale tè delle cinque in compagnia. La band americana è infatti una gradita presenza fissa nell’ambiente della musica indipendente da un bel po’ di anni, vuoi per il silenzioso e caldo carisma del frontman Matt Berninger, vuoi per le tentacolari collaborazioni dei fratelli Dessner, presenti in vesti di (poli)strumentisti, produttori o ospiti in molti dei progetti più interessanti degli ultimi anni (da Sufjan Stevens a Bon Iver, passando per i più giovanili Local Natives), vuoi per le abituali coccole della stampa, vuoi soprattutto per una invidiabile discografia in cui non si ravvisano evidenti cali sin dal terzo e fondamentale album Alligator, primo segno di crescita creativa dopo due pur ottimi album dalle più evidenti radici roots (l’omonimo The National, 2001, e Sad Songs For Dirty Lovers, 2003).
Fautori di una fortunata fusione tra sonorità classiche e cantautoriali, eleganti tonalità new wave nel puro spirito newyorkese e spunti moderni e originali, i National si sono imposti come punta di diamante della scena internazionale grazie a una brillante ricetta che giova degli spunti melodici dei fratelli Dessner (chitarra, tastiere, vari ed eventuali) e dell’impeccabile e morbida sezione ritmica dei fratelli Devendorf, su cui si staglia, imprevedibile, lo spoken word del sopramenzionato Matt Berninger. Gli album dei National, un incredibile e sempre cerebralmente progettato caleidoscopio di influenze e idee creative (non senza la giusta dose di energia), in un era di “tutto e subito” sono un raro esempio di prodotti fatti per essere compresi con calma, da far decantare, da sentire nelle ossa e nella pancia e poi gustare con cognizione.

Sleep Well Beast: i National che non ti aspetti
Da Alligator (2005), passando per Boxer (2007), per il più platinato e studiato High Violet (2010) e per il radio-friendly Trouble Will Find Me (2013), si arriva all’ultimo Sleep Well Beast (8 settembre 2017), atteso dai più come una delle uscite principali dell’anno sin dall’uscita del lead single The System Only Dreams In Total Darkness. Quest’ultimo pezzo aveva suscitato una certa perplessità tra i fan, sia per il suo evidente contenuto politico (facente parte di quel lungo filone di brani ispirati all’elezione a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump), sia per l’arrangiamento in cui, su un pad di synth morbidi e pianoforti distorti, si fa strada una chitarra mai così aggressiva, che sfocia persino in un assolo. Il ritmo sincopato del pezzo cozza ancor più con gli intenti dei successivi singoli: tra il beat elettronico e liquido di Guilty Party e i ritorni al passato della ballad Carin At The Liquor Store non si riusciva ad avere una idea chiara di quel che sarebbe stato il prodotto completo.
[restrict userlevel=”subscriber”]
Per definire appieno il sound di Sleep Well Beast, per la prima volta intimamente diverso dallo stile della band, conviene partire dalla storia recente dei membri dei National. È indubbio infatti pensare che alla genesi del nuovo sound dell’album, fatto di spunti elettronici e lead di chitarre quasi sghembe e sperimentali, abbiano parimenti contribuito sia la parallela attività da compositore di Bryce Dessner (sua la colonna sonora di The Revenant di Inàrritu), che ha dato ad alcuni pezzi un respiro più ampio e quasi cinematico, sia alcune sonorità più psichedeliche e taglienti sicuramente figlie del mastodontico progetto benefico, a nome di tutta la band, Day Of The Dead (2016), una compilation di 59 tracce tributo ai Grateful Dead, con la partecipazione di membri di Wilco, The War On Drugs, Yo La Tengo e varie altre band iconiche della scena alternative americana.

Sottili basi sintetiche e repentine svolte lisergiche si aggiungono quindi al sound di base dei National in Sleep Well Beast: quello che a un primo ascolto può apparire (esclusi un paio di episodi) come un album di ballad riesce a prendere vita e a risultare coinvolgente e ritmato sopratutto grazie a un meticoloso lavoro negli arrangiamenti, in cui da uno spunto apparentemente semplice prendono il via numerose strade, sottotracce che danno sensi mutevoli e diversi al brano, layers su layers di suoni che vanno a costruire il pezzo come un mosaico attentamente progettato, in un risultato sorprendentemente coeso. In Sleep Well Beast gli spunti orchestrali e ariosi, quasi briosi, presenti nel precedente Trouble Will Find Me diventano un synth glaciale, o una drum machine gommosa e pulsante come un battito cardiaco. La musica si va a far spazio tra i vuoti volutamente lasciati tra uno strumento e l’altro, vuoti che danno un effetto straniante almeno fino al momento in cui arriva la voce di Berninger, riempitivo rassicurante e familiare tra un sussurro graffiato e un respiro profondo.
Lo stesso stile vocale e lirico di Berninger, il potente perno fisso attorno cui ruotano gli affreschi dei National (se non da un punto di vista compositivo, quantomeno di focus dei brani, dato che il cantante ha sempre dichiarato di comporre e affinare le proprie parole su basi già quasi totalmente compiute dai colleghi) subisce una leggera quanto sostanziale modifica, divenendo più criptico e oscuro, volutamente artificioso, quasi ad accompagnare l’ascoltatore in un malinconico viaggio notturno, fornendo una fonte di calore umano negli arrangiamenti glaciali dell’album. Berninger raramente svetta sulle basi strumentali: in Sleep Well Beast il suo timbro baritonale resta nelle tonalità a lui più confortevoli, preferendo all’esplosione la quiete di una confidenza, quasi coperta e mantenuta in segreto dalla sezione ritmica. I testi, poi, sono puro bipolarismo: si oscilla con facilità dal canto d’amore alla cronaca di un rumoroso divorzio, tra avvocati e fallimenti. Lo stesso Berninger ha dichiarato che l’album parla espressamente di «matrimoni che si disintegrano», aggiungendo: «sono felicemente sposato, ma il matrimonio è una cosa dura; scrivo i testi insieme a mia moglie, parlando delle nostre difficoltà, è difficile scrivere in questo modo, ma è ciò che salva il nostro matrimonio».
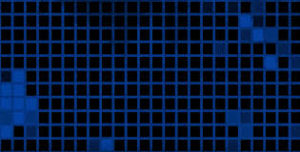
Track by track: la fine di una relazione, la bestia interiore
Nobody Else Will Be There apre l’album: un tappeto di drum pad e tastiere in avvicinamento avvolge l’ascoltatore in un incontro che sa di “bentornato”, una prima apertura della voce narrante sulle vulnerabilità alla fine di una relazione, il riconoscimento di una fine e la voglia di poter semplicemente tornare indietro, a tempi migliori. Il nervoso ed elegante stile alla batteria di Bryan Devendorf e una linea di chitarra semplice, efficace e molto effettata sostengono The Day I Die, in cui Matt esplora i sentimenti di rabbia e nostalgia (persino di ex compagne) e l’idea della morte, in seguito alla rottura, in un cantabilissimo uptempo che sicuramente regalerà più di una soddisfazione live. Walk It Back parte con un pattern di synth quasi house, su cui lentamente si costruisce un insieme di armonizzazioni di chitarre, sussurri, archi, rumori e campionamenti vocali, sostenuti da trascinanti fill di batteria; il pezzo cattura completamente l’attenzione, permettendo la completa e definitiva immersione nell’album.
In questo contesto di ascolto intensivo, persino The System Only Dreams In Total Darkness, prima straniante, ora acquisisce nuovi significati: un coro femminile apre il pezzo e l’attenzione viene definitivamente posta verso gli strati di tastiere al di sotto della nervosa linea di chitarra, in un altro dei pezzi più trascinanti e teatrali del lotto. Segue la ballad Born To Beg, un duetto per tastiere e voci, con interessanti controcanti, in cui Berninger espone in un intimo confronto le proprie inammissibili debolezze («I was born to beg for you/I’d cry, crawl/I’d do it all»). Turtleneck è l’ultimo dei pezzi trascinanti del lavoro: un po’ punk, un po’ inno dai riff lisergici e fuzzy fortemente derivato dall’esperienza DOTD, è un brano iconoclasta contro l’amministrazione Trump che pone ironicamente la discussione sul piano meramente estetico («Is just another man, in shitty suits, everybody’s cheering for/This must be the genius we’ve been waiting years for, oh no»); Turtleneck è un brano a suo modo interessante, pur essendo un anthem non perfettamente riuscito e a tratti fuori posto nell’economia di SWB.

Empire Line riprende le fila dell’album e ci riporta a quel mood malinconico e di rottura dei brani precedenti, dipingendo efficacemente una relazione come un viaggio in auto, così abituale, tenero e dilatato nel tempo e nello spazio, eppure dall’arrivo inesorabile, e insieme un tentativo di dialogo di coppia («Can’t you find a way?/You are in this too»), un testo in cui chiunque abbia vissuto una storia d’amore si potrà riconoscere. Il ritmo ballabile, quasi alla Kid A (Radiohead), di I’ll Still Destroy You spiazza: il brano si contorce su sé stesso evolvendosi a partire da sequenze elettroniche quasi staccate tra loro fino al ritornello; il testo riprende questo senso di (voluto) disorientamento, parlando di automedicazioni atte a star meglio «siano esse vino, erba o chissà cosa», mentre la parte strumentale continua a evolversi fino ad arrivare alla nervosa e ansiogena coda finale. Il pulsante pad di batteria di Guilty Party, secondo apprezzato singolo dell’album, riporta quiete e respiro, un flusso di coscienza a suo modo coerente sulla futilità della fine di una storia d’amore («I say your name/I say I’m sorry […] It’s nobody’s fault/No guilty party») su cui si stagliano, rassicuranti, avvolgenti, tastiere e synth.
La più classica ballad Carin At The Liquor Store e il lentone romantico da high school Dark Side Of The Gym aprono la parte finale dell’album dei National, posizionandosi a un livello più basso rispetto ai precedenti brani, quasi sottotono per arrangiamento e tematica, seppur il testo di Dark Side riesca a regalarci terrificanti immagini pastorali dai connotati quasi onirici («I have dreams of anonymous castrati/Singing to us from the trees/I have dreams of a first man and a first lady/Singing to us from the sea»). Sleep Well Beast, in chiusura, si sviluppa in modo multiforme: lunga più di sei minuti, parte come una ninna nanna, diventa una tavolozza impressionistica di rumori e sperimentazioni per poi chiudersi in sordina, mentre Berninger esplora la tendenza umana «a ibernarsi quando le cose diventano fottutamente strane» e fornisce una sorta di chiusura ricollegandosi testualmente all’iniziale Nobody Else Will Be There; concludendo quel lento addio che si è protratto per l’intero album e riempiendo il bicchiere di gin dopo aver chiesto compagnia nel primo brano, la voce tenta di affrontare quel dolore a mente fredda («Go back to sleep/Let me try/Let me figure it out»).

È un album mutevole, ricco di novità intriganti da digerire piano, Sleep Well Beast, un album più complesso del solito persino per gli standard dei National. Un percorso a suo modo nettamente diverso da quello che è stata la band finora, oscuro, irrazionale e malinconico, eppure limpido e brutale, come un iceberg di ghiaccio puro e trasparente. Un viaggio contraddittorio, probabilmente più astratto che reale, in cui impulsi e paure, voglia di far bene e istinti distruttivi si susseguono quasi senza demarcazione, uno spaccato della naturale pazzia della mente umana, una bestia metaforica che, però, per Matt Berninger «non è una cosa negativa, è il futuro», una sfida da affrontare, un proposito che fa male, ma mantiene in vita.
«I’ll still destroy you some day, sleep well beast, you as well beast».
[/restrict]
