«All’alba dell’11 febbraio [1963, N.d.R.], dopo aver preparato la colazione ai figli, Sylvia spalanca la finestra della loro cameretta e ne sigilla la porta; poi va in cucina, apre le manopole del gas, mette la testa nel forno e si toglie la vita. Sul tavolo aveva lasciato un biglietto per il vicino chiedendogli di chiamare il dottore».
Sylvia Plath scelse così la propria morte. Quel biglietto sul tavolo non venne letto in tempo, e sulla sua scelta cadde per sempre il dubbio. Resta la sua voce: segnata dalle relazioni familiari e amorose, dall’esigenza disperata di comunicare, dall’essere donna e voler essere Poeta.
L’uomo
Plath nasce nel 1932, in un sobborgo di Boston. Il padre Otto, entomologo, morirà otto anni dopo, lasciando il vuoto di una figura ingombrante, autoritaria, l’«uomo-panzer».
«I made a model of you,
A man in black with a Meinkampf look
And a love of the rack and the screw.
And I said I do, I do.
So daddy, I’m finally through».
L’autrice considera questo come primo «moment of being», parafrasando Virginia Woolf, in cui mettono radici sia la ricerca di perfezione che la tormenterà tutta la vita, sia il modello di uomo che odia ma a cui sembra condannata, il maschio del suo tempo, il marito dominante.
«Ed era proprio il suo suicidio [di Virginia Woolf, N.d.R.] che mi pareva di emulare nella nera estate del 1953. Solo che non sarei riuscita ad affogare. Immagino che sarò sempre molto vulnerabile, lievemente paranoica».
Il 1953 è l’anno della prima grave crisi depressiva, cui seguiranno un tentativo di suicidio, due cicli di elettroshock, una borsa di studio a Cambridge. Nel 1957, quando scrive queste parole, Plath è già sposata con Ted Hughes, già chiusa nella propria matrimoniale gabbia dorata.
Hughes sarà il primo curatore delle sue opere: anch’egli poeta, protagonista di una passione artistica e conflittuale che annichilirà lentamente, prima nell’infertilità e negli aborti, poi nei tradimenti di un padre di famiglia.
Plath scrive la propria rabbia, furia cieca verso Hughes e le sue amanti:
«In me c’è una violenza incandescente come il sangue della morte. Potrei suicidarmi, adesso lo so, o persino uccidere qualcun altro. Sarei capace di ammazzare una donna e ferire un uomo. Penso che ci riuscirei. Ho stretto i denti per tenere a bada le mani, ma mentre guardavo fisso quella sfacciata ho sentito in testa un’esplosione di stelle sanguinose e un desiderio sanguinario di [saltarle] addosso e ridurla in maledetti brandelli sanguinolenti e pulsanti».
Qualche mese dopo, l’autrice scriverà di una «sensazione amnesiaca», inquietudine ancestrale e violenta, in cui riconosce la figura del padre.
In Lady Lazarus, una delle liriche più famose, scrive:
«Herr God, Herr Lucifer
Beware
Beware.
Out of the ash
I rise with my red hair
And I eat men like air».
Nel testo si citano i suoi suicidi, la sua «arte nel morire», ma anche il rancore verso gli «Herr» che segnano la sua vita come macigni. La condanna di relazioni crude, aspre, incapaci di sostenere la ricerca dell’amore che Plath faceva sin da ragazza, come si dipinge in The Bell Jar. La campana di vetro è quella del mondo e della società in cui vive, il maccartismo, la donna colta come abbellimento di feste e cene. Definita dalle proprie relazioni con l’ambiente che la circonda, Sylvia racchiude tutto il peso di una donna inadatta, vulnerabile, e per questo imperdonabile.

Leggi anche: Un cammino di eterno dolore: la tragedia postsovietica del poeta Boris Ryzhy.
La madre
Il rapporto con Aurelia Plath sembra riempire il vuoto della figura del padre; testimoniato dalla raccolta Letters Home, il legame risulta estremamente complesso, quasi simbiotico. Riprendendo gli incontri con la vecchia terapeuta, Ruth Beuscher, Plath riconosce strutture relazionali che la bloccano, provocandole un forte astio verso la madre:
«Esprimere la mia ostilità per mia madre mi fa star bene da matti e mi libera dall’Uccello del Panico che mi sta sul cuore e sulla macchina da scrivere (perché?)».
Inoltre, riconoscerà le stesse dinamiche nel rapporto con Ted:
«[…] è come se non avessimo, ma parlo soprattutto per me, neanche un centimetro di pelle a separarci.»
Quella della madre sembra quindi una figura archetipica, che segna indelebilmente la sfera emotiva di Sylvia Plath. Non solo nel suo rapporto con essa, ma anche nella sua identificazione a modello: l’apparente infertilità è causa di dolore profondissimo, che porta la poetessa a sentirsi «rifiutata» dal mondo naturale. Sylvia è certa di essere sterile, terrorizzata dalla mancanza di un figlio.
«Tutto è sterile. Io sono parte delle ceneri del mondo, qualcosa da cui niente può germogliare, niente può fiorire né portare frutto».
Scrive che «morirà nel suo corpo di donna», vedendosi negato il riconoscimento nell’immagine di Aurelia. Ted, d’altra parte, in una delle sue poesie sentenzierà: «Cacciata dalla catena dei vivi, il Passato ucciso in lei, il Futuro strappato via». Il tema naturale viene ripreso in una delle liriche più toccanti di Plath, I Am Vertical:
«Then the sky and I are in open conversation,
And I shall be useful when I lie down finally:
Then the trees may touch me for once, and the flowers have time for me».
La Natura diventa immagine di un mondo in cui tutto è orizzontale, saldo, fatto di radici e grembi fertili. Disperatamente desiderato da Sylvia, interpretato nella pace della morte.
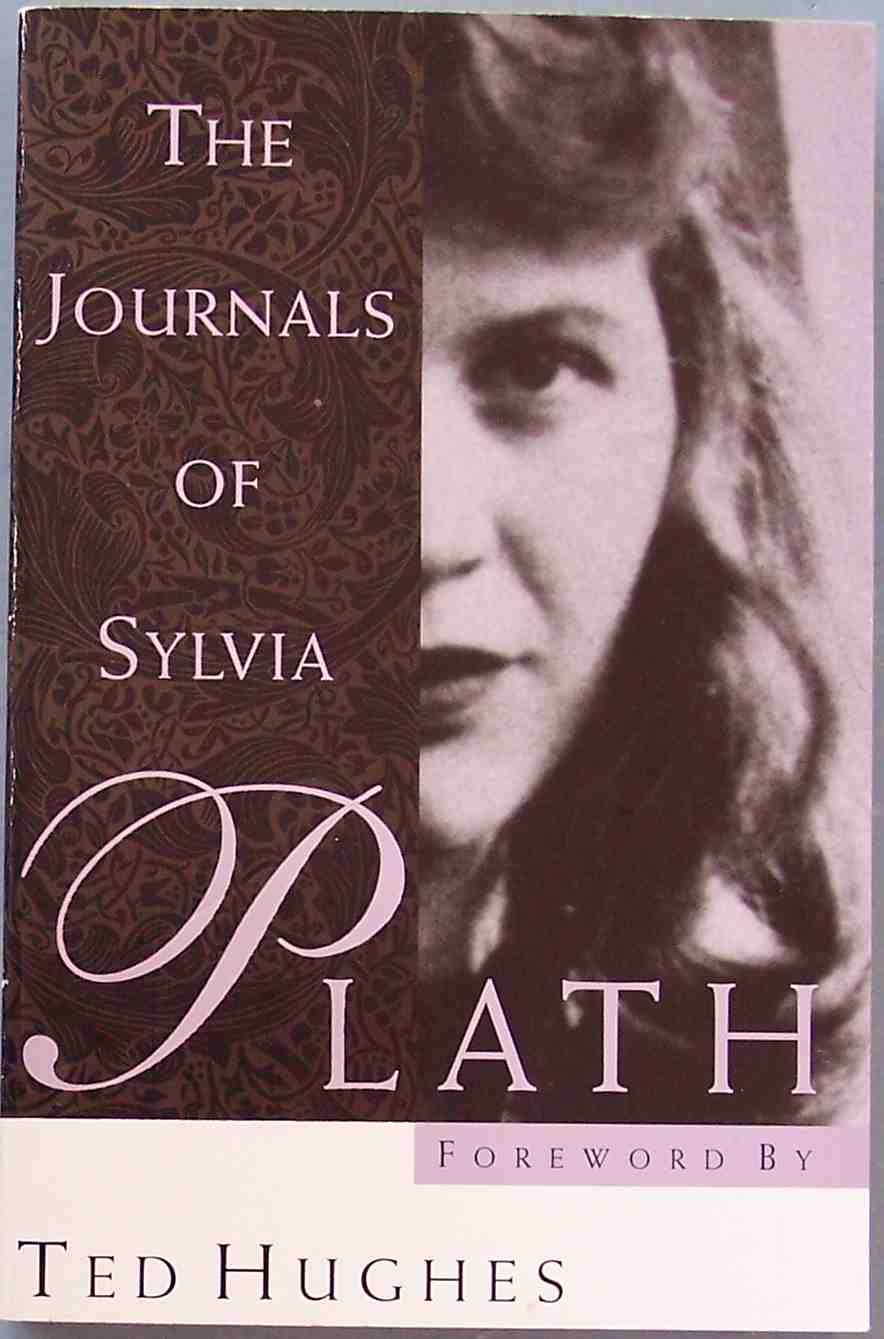
La dea
Jean S. Bolen, analista junghiana e attivista, nel 1984 pubblica Le dee dentro la donna: una nuova psicologia femminile. Nel saggio la dottoressa definisce un sistema archetipico innovativo tramite l’identificazione con gli attributi delle dee dell’Olimpo. In Jung troviamo particolare attenzione verso il valore del mito, specchio dell’inconscio collettivo; nel saggio in questione il patrimonio mitologico e religioso viene ulteriormente impiegato nella presentazione delle varie dinamiche psicologiche femminili.
L’autrice presenta casi clinici in cui il riconoscimento nella dea ha portato a un percorso di automaturazione e comprensione, e figure artistiche identificabili con precisi attributi archetipici.
Sylvia Plath viene citata come modello della donna Persefone: prima Kore, la «bambina della mamma», poi regina degli Inferi. Nel mito la dea è spesso guida nel mondo dei dannati, luce per i viandanti, dopo la metamorfosi subita nel rapimento e nel distacco dalla madre. Bolen riconosce in questa dinamica il racconto di Plath, ex paziente psichiatrica.
Del resto, le pubblicazioni di The Bell Jar e della raccolta poetica Colossus sono il culmine di un percorso di riconoscimento del dualismo conflittuale con la madre Aurelia e il marito Ted. Negli ultimi anni di vita, Sylvia lotterà apertamente con il «demone», come verrà ripetutamente definito; testimoniando la discesa agli Inferi e ritorno, in un continuo processo di morte e risurrezione. Qui viene forse restituito il maggior valore dei suoi scritti: l’accurata e puntuale annotazione di un processo sofferente, doloroso e potentissimo.
«I am only thirty.
And like the cat I have nine times to die.
This is Number Three.
What a trash
To annihilate each decade.
What a million filaments».
Riferimenti bibliografici:
Bolen Jean S. Le dee dentro la donna: una nuova psicologia femminile, Casa Editrice Astrolabio-Ubaldini Editore 1991
Plath Sylvia
- Ariel, Faber and Faber Limited, 1965
- Diari, Adelphi Edizioni. 1998
- Opere, Mondadori. 2002
- La campana di vetro, Mondadori Libri. 2016
